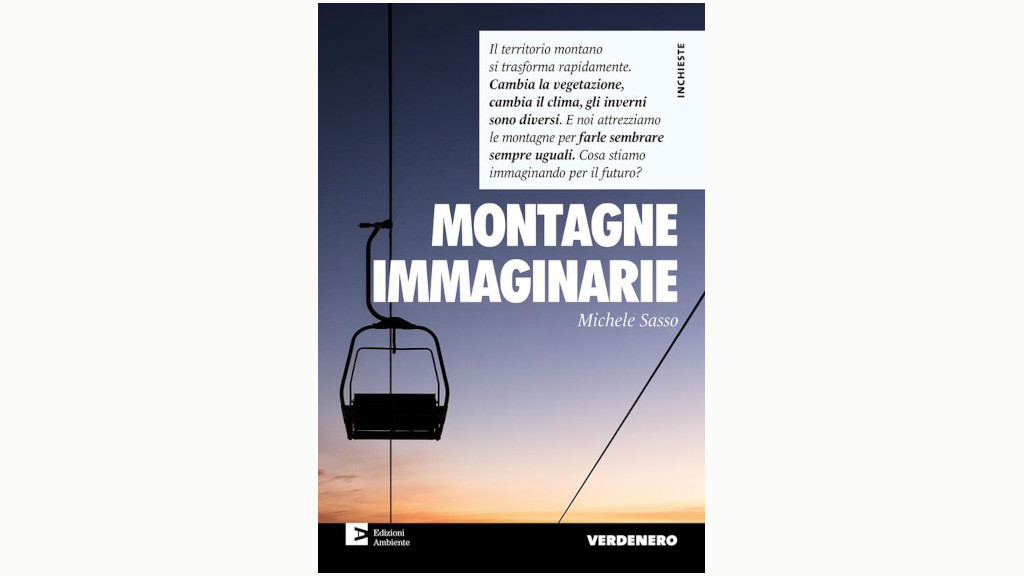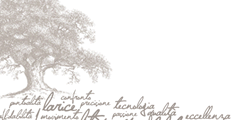Di Giuseppe Dematteis
Michele Sasso, Montagne immaginarie. Ediz. Ambiente. 2024, pp.199, є 19
Nel prologo l’autore, un bravo giornalista, ci dice che la montagna alpina e appenninica è sospesa tra essere un’appendice della città e aspirare a una nuova abitabilità responsabile. In ogni caso va preso atto che “la montagna come l’abbiamo conosciuta finora non esiste più” e bisogna rinunciare a “un immaginario fallace che, anno dopo anno, contribuisce alla sua distruzione” (p. 11). Il lettore così preavvertito troverà nelle pagine seguenti ampi esempi di queste contraddizioni. Nel titolo del primo capitolo, compare la parola “metromontagna”, segno che i lavori di Dislivelli (anche se non citati) servono a qualcosa. Ottima, in termini generali, la spiegazione di questo neologismo “che racchiude in sé un proposito radicale: unire sotto un unico sguardo ciò che naturaliter ci appare diviso, decostruendo l’alterità tra città e montagna” (p. 21). Peccato che subito dopo l’autore riduce i nuovi stili di vita che ne derivano a quello dei “nuovi nomadi metromontani “, un fenomeno di grande interesse, che però ha poco a che fare con il modello territoriale della metromontagna. Nel secondo capitolo è poi denunciata con ricchezza di esempi l’assurdità di una politica della snow economy “senza ceto medio e senza neve”, in cui le piste di neve artificiale sono srotoli di carta igienica e le seggiovie ondeggiano immobili sopra prati verdi. Altrettanto assurde sono certe risposte alla crisi dello sci di massa: gigantismo degli impianti, Ski Dome in stile Dubai (p. es. quello progettato a Cesana Torinese) e parchi divertimenti (slitte trainate da cani o da cavalli, kinder park, rafting sulla neve con i gommoni ecc.), mentre alle già da tempo sperimentate ciclovie per bici elettriche, si uniscono ora piste da moto e motoslitte. Il terzo capitolo tratta dei rovinosi impatti ambientali dei grandi eventi sportivi iridati e dei tentativi di opporvisi da parte di associazioni ambientaliste come Mountain Wilderness. Altrettanto minacciosi sono i progetti di nuovi collegamenti sciistici a fune, come quello della pista Gran Becca tra Cervinia e Zermatt, a danno del ghiacciaio del Teodulo. Il quarto capitolo risponde alla domanda: dove finiscono i milioni del Pnrr per la montagna? Lo vediamo nel dettaglio attraverso gli esempi alquanto discutibili di Livemmo, un borgo dell’alta Valsabbia (Brescia), di Dossena (val Brembana, Bergamo) e di Sarnano (Monti Sibillini). Segue una seconda parte dal titolo “Cambiare o morire di fronte ai cambiamenti climatici”, con un capitolo dedicato alle Alpi, dove oggi l’aumento delle temperature è quasi due volte quello medio globale e dove si registrano le maggiori variazioni climatiche stagionali. Viene illustrata la progressiva ritirata e la successiva estinzione dei ghiacciai, 180 dei quali sono già scomparsi negli ultimi decenni. Particolarmente allarmante è il disgelo del permafrost, lo strato superficiale permanentemente gelato che fondendo rende instabili le pareti rocciose. Un altro effetto del riscaldamento globale è la “fuga degli ecosistemi verso l’alto”, con conseguenze negative sull’erogazione dei servizi ecosistemici e la necessità di azioni di adattamento e di ripristino, per potere ancora praticare l’agricoltura, l’allevamento e la gestione dei boschi. Il sesto capitolo “L’agricoltura allarga i suoi confini” passa in rassegna le inevitabili trasformazioni colturali, mette in guardia contro i rischi della monocultura, segnala i problemi derivanti dalla ridefinizione delle aree di produzione tipiche (come nel caso del prosecco) e le storture derivanti dall’accaparramento dei pascoli da parte dei grandi allevatori della pianura allo scopo di intercettare i fondi europei. Degli ecosistemi forestali si tratta nel settimo capitolo, in cui si esaminano le diverse posizioni relative alla gestione forestale sostenibile (minacciata tra l’altro dal bostrico) e alla pianificazione dei tagli, con riferimento all’evoluzione storica dei “boschi banditi”, delle proprietà demaniali e del modello Tarvisio dei prelievi di legname. L’ottavo capitolo affronta i problemi dell’emergenza idrica e quello delle concessioni per l’imbottigliamento delle acque minerali. Esemplare il caso dell’acqua di Sant’Anna di Vinadio (Cuneo) che, con la produzione annua di 1,5 miliardi di bottiglie, paga alla Regione l’acqua che vende per un valore che corrisponde all’1% del suo fatturato, mentre provoca inquinamenti e vibrazioni a danno dei paesi della valle Stura di Demonte, attraversati dal flusso continuo di suoi tir. La seconda parte del libro termina con un capitolo sulle mille frane dell’Appennino e sui danni delle alluvioni, che, come nel caso macroscopico dell’Emilia-Romagna, mettono in luce le conseguenze del consumo di suolo (in Italia circa 20 ettari al giorno), che procede a un ritmo non giustificato dalla crescita demografica. Urbanizzazione selvaggia, copertura di cemento e asfalto, corsi d’acqua “tombati” (solo a Genova ce ne sono per la lunghezza di 52 km), spiegano gli ingenti danni degli eventi alluvionali ricorrenti (e prevedibili) e delle vistose “cicatrici” che sfigurano i paesaggi, a cominciare dalle frane. Come rimedio viene indicata la rinaturalizzazione dei fiumi secondo le linee dettate dalla Nature Restoration Law europea e, nell’Appennino, il potenziamento della rete di Natura 2000. L’ultima parte del libro parla della sostenibilità economica e sociale della montagna “di mezzo” abitabile, una sfida raccolta da chi decide di rimanere o di andarci a vivere: due categorie accomunate nel concetto di restanza, capace di dar vita a nuove comunità, seguendo le indicazioni del suo inventore, l’antropologo Vito Teti. Gli ultimi due capitoli sono dedicati a tre storie dell’Appennino meridionale (Gambarie, Dolomiti lucane e Aliano) e al caso esemplare di Ostana, che “guida la riscossa del mondo dei vinti”. L’epilogo conclusivo, in assenza di un piano strategico nazionale per la montagna, è piuttosto pessimista. Una postfazione di Antonio Nicoletti di Legambiente individua nella lotta ai cambiamenti climatici e allo spopolamento i due principali obiettivi delle politiche pubbliche per mantenere abitata e produttiva la montagna italiana.