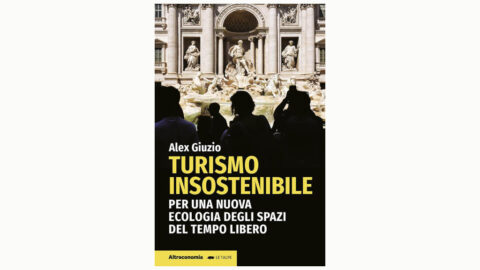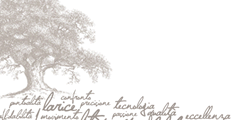di Oscar Gaspari (Fondation Émile Chanoux-LUMSA Roma)
Giampiero Lupatelli, economista territoriale, Presidente Caire Consorzio (già Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia – Urbanistica) e socio fondatore dell’Archivio Osvaldo Piacentini di Reggio Emilia, mi racconta del Festival di Primavera La Montagna del Latte scende in città, che si tiene a Reggio Emilia per riflettere sulle economie della montagna.
La Montagna del Latte scende in città è frutto di due iniziative distinte: La Montagna del Latte e la sua discesa in città. La Montagna del Latte è un’idea di una decina d’anni fa, nata da precise contingenze: in primo luogo la crisi dovuta alla discesa del prezzo del formaggio parmigiano-reggiano nel 2012-13 [a seguito della crisi economica internazionale iniziata nel 2008] che ha ridotto i margini di redditività della produzione, una produzione che, essendo legata quasi tutta ad aziende cooperative, si è ripercossa direttamente sul prezzo del latte pagato alle aziende agricole, un prezzo che è almeno quattro volte più alto del prezzo del latte alimentare.
Il latte dal quale viene ricavato il parmigiano-reggiano ha così un prezzo che consente di mantenere vive aziende agricole zootecniche familiari, dove solo da poco incomincia ad essere impiegato anche il lavoro salariato, di indiani e pakistani soprattutto. La crisi è stata più grave in montagna perché lì il costo di produzione è più alto, mentre il prezzo del parmigiano, tendenzialmente, è lo stesso per tutte le aziende.
La crisi del prezzo è arrivata subito dopo che l’Unione Europea aveva varato un regolamento che riconosceva il marchio dei prodotti di montagna, a seguito del quale il Consorzio di tutela del parmigiano-reggiano aveva prodotto un disciplinare specifico per il parmigiano-reggiano di montagna, marchiato come un prodotto distinto e diverso e, come tale, con un prezzo maggiore. Un prezzo maggiore che però, per via della crisi, non poteva essere applicato.
Una spinta negativa, quella della crisi di mercato, una opportunità positiva, quella del marchio: da qui l’idea di seguire nel territorio della montagna reggiana una strategia territoriale che coinvolgesse tutta la comunità e che mettesse al centro dell’attenzione il parmigiano-reggiano di montagna.
Questa strategia territoriale, locale, ha poi sfruttato un’altra opportunità: la Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) che doveva essere sperimentata in una serie di aree di intervento pilota nelle quali la Presidenza del consiglio dei ministri, vari ministeri, agenzie, le regioni e il sistema locale, condividessero una strategia comune e dei progetti comuni.
La SNAI ha trovato nel progetto per la montagna reggiana una chiave interpretativa per trasformare una grave crisi in una grande opportunità: così è nata La Montagna del Latte, un progetto che, per sua fortuna, ha avuto successo.
Dopo aver provato strade diverse siamo riusciti a convincere la Regione Emilia-Romagna a dare, nel campo dei progetti di filiera, una premialità addizionale straordinaria ai progetti nati nell’ambito della Strategia delle aree interne, tant’è che il progetto di filiera del parmigiano-reggiano di montagna della Montagna del Latte della montagna reggiana è risultato il primo nella graduatoria regionale.
Il giorno dopo il grande successo di questo progetto l’assessora regionale all’agricoltura dell’epoca, Simona Caselli, che avevo incontrato per caso al bar della Regione, mi ha detto che sì, certo, avevamo vinto il bando, ma dello specifico sostegno premiale non ne avevamo bisogno, perché avremmo comunque avuto dei finanziamenti perché eravamo stati bravissimi a costruire progetti interessanti ed efficaci. Io le ho risposto che quel riconoscimento era stato invece fondamentale perché, senza quel riconoscimento all’intera comunità locale da parte della Regione, noi, i dodici caseifici sociali, i trenta più grandi allevatori che avevano partecipato al progetto con propri finanziamenti, gli altri cento allevatori coinvolti nel conferimento del latte ai caseifici, le strutture di ricerca e informazione, tutte queste strutture non le avremmo mai messe insieme, come non eravamo mai riusciti a metterle insieme, in un unico progetto, nei quarant’anni precedenti.
La comunità montanara ha scommesso su quel progetto in favore del parmigiano-reggiano di montagna perché interpretava il proprio desiderio e le proprie aspettative di sviluppo e di progresso ed è questo che ha consentito di mettere in moto l’innovazione, una innovazione che non è per sempre, perché si deve misurare continuamente con le sollecitazioni del mercato. Il progetto, però, è stato comunque importante perché ha fatto conoscere La Montagna del Latte in tutta Italia.
Ad un certo punto, però, ci siamo trovati con un progetto che era stato conosciuto e riconosciuto in tutta Italia, era il progetto della SNAI di maggiori dimensioni, quello che aveva avuto i migliori risultati nella spesa degli investimenti ottenuti, il 92% delle risorse disponibili quando, nel 2022, la media nazionale era del 18%, erano in molti quelli che venivano da noi per conoscere il nostro progetto, ma l’attenzione della nostra città era modestissima. Come dice un proverbio inglese Nessun genio lo è per il proprio maggiordomo, oppure, come dicevano i latini Nemo propheta in Patria.
Ci siamo quindi posti il problema di costruire un rapporto con la nostra città, che aveva un’immagine stereotipata della propria montagna, una città che non si stava accorgendo di tutto quello che stava succedendo in montagna.
È nata così una iniziativa, piccola, che è consistita nell’organizzare, nel 2023 in quattro sabati a maggio e nel 2024 in cinque sabati, tra aprile e maggio, degli incontri che mettessero in rapporto i temi della montagna con le culture urbane, chiamando ogni volta un testimone, un osservatore nazionale a parlare della montagna reggiana, per far capire ai reggiani che della loro montagna, il resto del mondo, se ne accorgeva. E devo dire che questo tentativo, un qualche riconoscimento, lo ha ottenuto.
Certo, saldare culture diverse è difficile. Bisogna pensare che la distanza tra la montagna e la pianura, in Emilia forse, ma sicuramente a Reggio-Emilia, è una distanza enorme, è una distanza antropologica, cambia il cibo e cambiano le bevande, tra la pianura e la montagna. In pianura si beve il lambrusco e in montagna si beve il vino toscano, un esempio per capire quanto si è lontani nella vita di tutti i giorni. Tuttavia si scopre sempre più che la pianura, e soprattutto la città e la montagna, hanno bisogno l’una dell’altra, non possono vivere l’una senza l’altra.
La montagna offre una quantità di servizi di varia natura. Le cose più elementari: la qualità del cibo o la qualità delle acque, che scendono dalla montagna ad alimentare gli acquedotti della pianura. Il paesaggio, l’ambiente, la funzione di cattura dell’anidride carbonica e di mitigazione del rischio climatico in positivo. E in negativo la necessità di ridurre il rischio legato all’abbandono del territorio della montagna, che si riflette sulla pianura in termini di alluvioni ed esondazioni, eccetera.
Città e montagna debbono stare insieme, debbono essere capaci di fare i conti l’una con l’altro, questo è il senso dell’iniziativa La Montagna del Latte scende in città.

Di chi è stata questa idea?
Allora, La Montagna del Latte ha avuto successo non solo nel contesto SNAI. La montagna reggiana è stata scelta come una delle tre aree pilota del nuovo programma delle Green Community nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e quindi è stata riconosciuta da un nuovo soggetto istituzionale nazionale. E poi c’è la Regione Emilia-Romagna, che all’inizio ha visto questa iniziativa con sospetto, perché sembrava che la SNAI occupasse uno spazio locale proprio della Regione e per questo, inizialmente, ha fatto qualche resistenza. Poi, con il tradizionale pragmatismo degli emiliani, la Regione si è accorta che il progetto funzionava e ci ha investito tantissimo, l’ha accompagnato, rilanciato, e ne ha seguito il modello per i prossimi cinque anni, estendendolo al territorio regionale.
La città è un soggetto difficile da “incastrare”, e qui è entrato in causa l’Archivio Osvaldo Piacentini. L’Archivio Piacentini è una istituzione formata dal Comune e dalla Provincia di Reggio-Emilia, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Cooperativa architetti e ingegneri, che sono tra i soci fondatori. Tra i soci fondatori ci sono anche le persone, con le loro idee. L’Archivio Piacentini è una istituzione culturale che vuole conservare un patrimonio archivistico e valorizzare un patrimonio di idee.
Osvaldo Piacentini [1922-1985] è una figura importante anche per l’attenzione prestata dalle culture urbane alla montagna. Piacentini era un urbanista che ha sempre dedicato attenzione alla montagna, dai tempi del Progetto ‘80 [P’80 sigla del Secondo Programma Economico Nazionale (1971-1975), del 1968, promosso dal ministero del Bilancio e della Programmazione economica diretto da Giorgio Ruffolo]. Nel 1980 ha elaborato il Progetto Appennino per la Regione Emilia-Romagna, che è considerato da molti uno dei protetti territoriali, su grande scala, più interessanti a livello nazionale.
E anche lì guarda caso c’era, in qualche modo, la questione del rapporto con la terra, con la zootecnia, con il parmigiano-reggiano, con il latte. Il Progetto Appennino cercava di ricostruire i termini del bilancio ecologico del popolamento della montagna a partire dalle risorse primarie. Nel nome e in ricordo di Piacentini l’Archivio ha pensato di essere l’agenzia giusta, per il proprio carattere culturale, per avvicinare la città, propria socia innanzitutto e la Regione, punto di riferimento fondamentale, a questa esperienza della montagna, e così è nata questa iniziativa.
C’è stato qualche segnale positivo in risposta a questo progetto. L’anno scorso, per esempio, proprio in relazione al successo di queste politiche, l’Associazione industriali di Reggio-Emilia, per la prima volta, ha spostato la propria assemblea generale dal Teatro Romolo Valli di Reggio-Emilia, al Teatro Bismantova di Castelnuovo Monti [nell’Appennino Reggiano]. Si è trattato di un importante riconoscimento al progetto della Montagna del Latte, e della Green Community, da parte di un soggetto che esprime una parte essenziale degli interessi della città.
Le ragioni dell’interesse del mondo industriale verso la montagna sono varie. Il tema della sostenibilità, per esempio, con l’acquisto dei crediti di sostenibilità che il Parco nazionale dell’Appennino Tosco-emiliano è in grado di offrire e di mettere sul mercato grazie alle iniziative politiche e i progetti che sono stati finanziati dalla SNAI e dalla Green Community; le risorse energetiche; l’attenzione al capitale umano e alla sua formazione tecnica, rispetto alle quali la montagna ha sempre avuto un ruolo nel grande distretto meccatronico qual è quello della Provincia di Reggio Emilia che in montagna c’è poco, ma non è del tutto assente, soprattutto nella fascia più vicina alla città. Per tutto questo il mondo industriale ha pensato che la montagna fosse un interlocutore rilevante, si tratta di un buon segnale, per immaginarci che anche altri presteranno attenzione alla nostra montagna.
Vorrei ora che approfondissi l’istituzione Archivio Osvaldo Piacentini e il suo rapporto con il mondo della montagna. Un urbanista che si occupa di montagna in modo continuativo e i suoi successori che proseguono lungo la stessa strada, è senz’altro di grande interesse, anche per il fatto che avviene in una città, come Reggio Emilia, che ha lunga tradizione in questo senso, penso a Meuccio Ruini, anche se magari Ruini, di fatto, non è mai stato un riferimento vero?
No, Meuccio Ruini [1877-1970, politico promotore della questione della montagna nel primo ‘900], per Reggio Emilia in questo momento è una via, ma anche Osvaldo Piacentini è una via, a lui recentemente intitolata, ma in questo caso si tratta di una presenza più forte nel corpo della città, incarnata nella storia della Cooperativa degli architetti e degli ingegneri di Reggio Emilia (CAIRE) che dal 1947 in avanti ha continuato a lavorare nella città, in Italia e anche nel mondo. Osvaldo è stato l’urbanista di questo gruppo, quello che si è occupato di città e che ha unito in questa attenzione due sensibilità: quella professionale e quella civile.
Il rapporto di Osvaldo con la montagna nasce molto presto quando, giovanissimo, dopo essere stato internato in Germania come militare, al ritorno in Italia diventa partigiano e va in montagna nelle formazioni cattoliche delle Fiamme Verdi, mentre il rapporto con Giuseppe Dossetti lo guida in questo universo. Osvaldo è stato poi anche il curatore dell’installazione del Museo della Resistenza della Repubblica partigiana di Montefiorino, della cui storia lui stesso è stato un pezzettino; non è stato un partigiano combattente di primo piano, ma ha vissuto quella esperienza e, soprattutto, è diventato interprete di una lunga tradizione politica che ha nella montagna reggiana, e nella montagna emiliana in termini più ampi, un forte radicamento e una forte presenza del mondo cattolico.
La dimensione di una religiosità profondamente incardinata nei riti della vita quotidiana nella montagna, è un tratto che ha consentito a Osvaldo di essere un riferimento importante per le amministrazioni democristiane in montagna, ma riusciva ad esserlo anche in città, a Reggio Emilia, per le amministrazioni social-comuniste. È stato in grado di elaborare approcci più moderni anche in montagna, prima con interventi soprattutto nell’edilizia scolastica, poi con azioni di pianificazione urbanistica, poi in una logica più generale di promozione e pianificazione dello sviluppo economico, nei primi piani di sviluppo delle Comunità Montane negli anni ’70 del ‘900.
Io ho conosciuto Osvaldo Piacentini lavorando con lui ai piani di sviluppo delle Comunità Montane delle Marche, dopo un anno mi ha trascinato nell’Appennino reggiano, nella primavera del 1978. È lì che è nato il mio rapporto con La Montagna del Latte che ormai si avvicina a compiere cinquant’anni di frequentazione professionale costante e ripetuta e che negli ultimi dieci anni è riuscita, forse, a dare il meglio di sé.

Puoi parlare adesso di quel progetto cui stai lavorando nel Canavese, di cui mi hai accennato prima…
Io ho una montagna di nascita, che è la montagna da cui viene mio padre che è quella tra Umbria e Marche, ho poi una montagna di elezione, che è La Montagna del Latte, la montagna reggiana, nella quale sto lavorando da quasi cinquant’anni ed ho ottenuto risultati che sono molto soddisfacenti anche dal punto di vista umano e professionale ed ho una terza montagna che è entrata nel mio cuore: quella del Canavese. È una montagna che mi affascina anche per come su di essa si è proiettata l’ombra lunga di Adriano Olivetti, una figura con la quale, in via mediata, ho un rapporto importante, perché il mio maestro di economia è stato Giorgio Fuà, che è stato uno stretto collaboratore di Adriano Olivetti, il suo consigliere economico nell’esilio svizzero nel 1944-45, presidente dell’Istituto Adriano Olivetti e di tante istituzioni della storia olivettiana.
Mi è capitato, abbastanza per caso, grazie a Marco Bussone, presidente dell’Uncem, di incontrare dei suoi amici piemontesi amministratori di una piccola realtà: il Comune della Val di Chy, nato dalla fusione dei comuni di Alice Superiore, Pecco e Lugnacco, che tutti insieme superano di poco i mille abitanti. Quegli amministratori hanno deciso, con il gesto coraggioso della fusione, di voler investire un po’ del premio che lo Stato riconosce ai comuni che partecipano al processo di fusione, in una esplorazione del futuro, una sorta di piano di sviluppo del comune.
Io ho questi ormai amici carissimi, ai quali mi accomuna la stessa ingenua passione, l’aspirazione al riscatto da una quotidianità mediocre, con l’idea di far rivivere un’ombra olivettiana su quel territorio. A loro ho detto: “Ma si, proviamoci”, ma sapevamo tutti molto bene che o riuscivamo a muovere all’unisono anche gli altri comuni della valle, oppure lo sforzo molto difficilmente avrebbe prodotto risultati.
Siamo stati fortunati, loro sono stati bravi, e nell’arco di circa otto mesi siamo riusciti a far sottoscrivere un accordo di programma, per un piano di sviluppo, a tutti i comuni della Val Chiusella, una valle alle spalle di Ivrea che sale verso la Val d’Aosta. Un piano di sviluppo che non è stato chiesto da nessuna legge e che non è stato imposto da nessuna opportunità esterna, se non dalla loro volontà di guardare con fiducia al futuro con un percorso strutturato. È stato un buon investimento perché ci ha consentito di arrivare poi ad occasioni che si sono proposte con il PNRR, con il Fondo per la Montagna, con i bandi indetti da vari Ministeri in favore dei piccoli comuni. Grazie ad una strategia di azione comune abbiamo elaborato progetti pronti e maturi che oggi fanno sì che più della metà del piano di sviluppo della Val Chiusella sia diventato un progetto di intervento sostenuto da finanziamenti statali e regionali che si stanno realizzando oggi e che si realizzeranno nei prossimi anni.
Mi verrebbe da dire che quella era quasi una missione impossibile, una missione che dà l’idea dell’importanza di dare credito alla realtà minuta di questo nostro territorio nazionale, che sembra poca cosa, ma stiamo parlando di montagna, e stiamo parlando di quasi 3.500 comuni, quasi la metà del territorio nazionale, che non sono tanto in termini di popolazione, circa 10 milioni di abitanti, ma sono tantissimo in termini di superficie del territorio e che rappresenta più di due terzi del valore dei servizi ecosistemici ambientali che si producono in questo Paese.
È un territorio frammentato, frazionato, che ha difficoltà di governo, che ha difficoltà di rappresentanza, ma che, se gli si dà fiducia e se con “lui” si stabilisce un rapporto di responsabilizzazione, può avere successo, com’è accaduto nei casi migliori della SNAI e com’è accaduto nelle Unioni di Comuni e con altre politiche che hanno riconosciuto il territorio come elemento di integrazione e del fare. Altri territori, invece, hanno deciso di spendere disordinatamente i soldi, oggi per questo obiettivo, domani per un altro, oggi seguendo l’idea di un ministro e domani seguendo quella di un sottosegretario, ma gli spazi per fare delle cose importanti ci sono.
Una domanda sociale in montagna oggi, e molto forte, c’è: nel 2022-2023 la montagna italiana ha conquistato una parte significativa di popolazione di provenienza dalle città e dalle aree metropolitane ed è una novità, perché nella prima decade del ventunesimo secolo c’era stata una migrazione verso la montagna, ma si trattava di una emigrazione di popolazione extracomunitaria andata a riempire i vuoti demografici della montagna. Oggi, invece, siamo di fronte a una popolazione italiana, anche giovane, anche colta e dotata di competenze, che ha scelto la montagna come il luogo in cui impiegare una parte del proprio progetto di vita.
Nel tempo contemporaneo niente nella vita è per sempre, c’è chi parla di in un secolo nomade, si va in montagna non come una scelta assoluta, ma per un interesse, per un interesse forte verso questi territori. Vedremo nei prossimi anni se questa ripresa di attenzione e di interesse riuscirà a mettere radici profonde. Riuscirà a farlo, secondo me, se progetti come questi di cui abbiamo parlato riusciranno a incontrare la sensibilità dei decisori locali, della classe dirigente, ma forse è troppo ambizioso chiamarla classe dirigente, si può parlare piuttosto di una rappresentanza locale, ma a questa rappresentanza bisogna dare credito, sapendo però anche chiedere una forte assunzione di responsabilità.