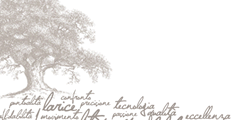di Paola E. Boccalatte, Enrico Camanni, Massimo Venegoni
Le frontiere sono uno dei temi più ineffabili del nostro tempo. I segni che le individuano sulle carte cambiano rapidamente. Le loro esistenza, rilevanza e sostanza generano continui conflitti e contese, e il termine assume valenze diverse nelle varie discipline sociali, scientifiche e umanistiche. Credere di poter attribuire un’interpretazione definitiva al tema e di rinchiuderlo con qualche definizione nelle sale di un museo è del tutto irrealistico, e tale si è rivelato al Forte di Bard, dove il precedente allestimento del Museo delle Frontiere, inserito nella parte terminale dell’Opera Ferdinando, venne inaugurato nel 2012. Era l’esito di un progetto che rimontava ad alcuni anni prima, e che già costituiva il riadattamento di un’idea risalente ad ancora prima. Il percorso cominciava laddove terminava una lunga corsa a rotta di collo fra le forme delle fortificazioni alpine nei secoli. Un percorso ampio, corposo, che nella parte finale, già penalizzato dalla “museum fatigue”, offriva ulteriori elementi di complessità. L’Associazione Forte di Bard ha quindi espresso il desiderio di ripensare questa porzione del Museo.

Photo Pierfrancesco Grizi – Forte di Bard
La nuova proposta progettuale è intervenuta sia sulla narrazione sia sull’accessibilità. Ci si è domandati quale potesse essere la funzione: ‘fermare’ in un’istantanea quanto accade troppo velocemente? Rendere visibili contrasti e ombre? Tenere accesa una luce su quanto rischia di finire in ombra? Era forse venuto il momento di uscire dalla confortante raffinatezza di un pensiero ricercato e inespugnabile e andare alla ricerca di un’idea diversa, assumendosi qualche rischio. Così è cominciata una nuova fase per l’Opera Ferdinando, in cui sono confluite esperienze, ragionamenti, desideri. Dalla scoperta di un giornalista che ci ha lasciato troppo presto all’ascolto degli abitanti di un’isola all’estremo del Paese, dalla nenia mormorata da un grande cantautore ai mille complessi passaggi tra il Frejus e Ventimiglia, dalle parole taglienti di chi ci ha insegnato a lavorare “senza frontiere” all’unisono di cento campanacci, dalle rovine di un villaggio nei boschi alle inchieste di sessant’anni fa, dai racconti degli altipiani alle interviste che mancano. Mentre il percorso delle Fortificazioni metteva al centro i muri, le strutture, le pietre, le macchine, le armi, l’ultima parte sarebbe tornata alle persone. Mentre il racconto delle fortificazioni era storia di guerre, strumenti, strategie, il seguito del percorso si sarebbe staccato da questo orientamento per veicolare un messaggio di pace.

Photo Pierfrancesco Grizi – Forte di Bard
Dopo la discesa tra fortezze e battaglie i materiali si fanno più leggeri, diafani, a suggerire il superamento della militarizzazione. I teli lasciano trasparire “ombre” di persone, frammenti di umanità che ci riportano alla dimensione reale. I primi interventi con i teli si inseriscono nel vecchio allestimento, accostandosi ai materiali pesantemente materici (acciaio, cemento, pietra) per poi diventare sempre più presenti.
Discesa la scala di pietra inizia il racconto del Novecento, e l’esposizione affianca alla storia militare i riferimenti alla gente comune. Le guerre non si sono mai arrestate sulle Alpi, e così pure lo sviluppo di tecniche di offesa e difesa, ma le popolazioni hanno continuato a viverci e conviverci, nonostante tutto, costrette talvolta a fuggire, altre volte a espatriare, quasi sempre a contrabbandare per sbarcare il lunario. Così lo spazio dedicato alle fortificazioni e quello sulle frontiere si compenetrano e le persone prendono la parola mentre il loro volto perde definizione. Il percorso sfuma visivamente verso il fondo, facendosi all’apparenza lieve e parlando sempre più attraverso il vissuto della gente, per allusioni, ombre, mettendo in luce le contraddizioni del nostro tempo. La vista si sfoca nella sovrapposizione di piani diafani, in un corridoio che non è più il corpo del forte ma è spazio di respiro. La scelta è chiara: non si tratta di esporre il visitatore alla violenza delle immagini né di indulgere sul piano retorico e moralizzante. Il Museo invita a un’osservazione profonda e le figure si definiscono con un grado di attenzione più alto. È il visitatore a decidere se lasciarsi toccare. L’ultimo ambiente si apre con i versi del cantautore Gianmaria Testa: “Quanto meno / un’ombra / racconta / di una luce.” Qui si raccoglie la soluzione del tema-guida delle ombre. L’ultima sala non affronta il tema dell’immigrazione dal punto di vista di chi sceglie di partire o è costretto a farlo, ma racconta della nostra capacità di confrontarci con l’‘altro’ e di condividerne il destino. La chiusura è in soggettiva, nelle voci femminili del film di Daniele Gaglianone Dove bisogna stare (2018), una scelta antiretorica che richiede disponibilità di ascolto e delicatezza di sguardo.