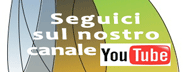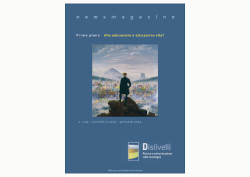Microcosmi alpini
I microcosmi alpini di cui si occupa il libro compongono un puzzle di contesti locali sospesi tra il non più e il non ancora, luoghi abitati da soggetti semplici spesso attraversati localmente da logiche complesse afferenti alle forme più avanzate del capitalismo delle reti (infrastrutture per la viabilità, reti dell’energia, ecc.), tra saperi contestuali e saperi formali, tra mondo dei vinti e avanguardie agenti, tra smart city e smart land. Sono esempi di ritorno nei territori dell’abbandono, dello spaesamento, per immettervi saperi, progetti, visioni di un futuro possibile, partendo dal margine che si fa centro. In grande, a ben vedere, è quello di cui necessita il paese per ritrovare voglia di futuro. Un margine che si fa centro non tanto o non solo dal punto di vista mediatico come le complesse vicende della Valle di Susa, area sulla quale l’attenzione viene giustamente posta soprattutto a ciò che accade ai margini del cratere dei cantieri per la Tav, ma soprattutto perché ci parla di un mondo che viene avanti, piuttosto che di uno che va declinando, come vorrebbe l’immaginario alpino prevalente. Certo c’è il rischio di sovrarappresentare la fenomenologia dei “ritornanti” alla montagna, come spesso accade a chi prova a esplorare tendenze nascenti, seppure in questo caso piuttosto consolidate nel tempo. Ma si tratta di un rischio che vale la pena di correre per molteplici ragioni. Da un lato per produrre maggiore consapevolezza collettiva rispetto a un fenomeno che occorre non solo rappresentare, ma anche incoraggiare, mi permetto di dire, in modo militante. D’altro lato alla rappresentazione è sotteso uno stimolo affinché la politica e le politiche accompagnino con maggiore decisione queste tendenze in atto in modo spontaneo, spesso sostenute da una chiara scelta di localizzazione da parte di persone e famiglie alla ricerca di un luogo sul quale investire risorse economiche, sociali e culturali in territori segnati da lunghe derive di abbandono e spopolamento.

Ovviamente non tutti ritornano alla montagna con motivazioni “forti” sotto il profilo etico, culturale o finanche ideologiche (neorurualismo, decrescita, ecc.), ma anche per motivi di convenienza economica o di necessità, com’è il caso di tanti migranti (ecco un pezzo di composizione sociale tutt’altro che marginale) provenienti dall’Albania, dalla Romania o dal Marocco. Ma anche in questo caso, come si evince dalle interviste compiute in loco, la convenienza può trasformarsi in valore di legame, in socialità progressiva, a testimonianza del fatto che la montagna non è necessariamente il luogo del rifiuto della modernità, di chiusura al mondo e così via. Certo le Alpi si connotano talvolta come aree tristi, intendendo con ciò evidenziare le difficoltà degli autoctoni nel metabolizzare la modernità di cui spesso sono stati e sono talvolta ancora oggi subalterni. E di questo gli autori sono ben consapevoli. Non di rado l’inserimento di nuovi arrivati motivati a radicarsi avviene sullo sfondo di un contesto poco accogliente di cui i ritornanti tendono quasi inevitabilmente a porne in discussione le debolezze, i limiti e le forme culturali inchiodate a un simulacro di immaginario agro-silvo-pastorale rimasto fermo nella storia. Al di là delle ben documentate analisi sui flussi demografici e dei relativi tentativi di spiegarne le cause e delle altrettanto condivisibili analisi relative al tipo di relazione sussistente tra terre alte e aree pedemontane, sono le ricostruzioni relative alle nuove forme di insediamento e alle motivazioni sottese alla scelta di ritornare ad apparire affascinanti. Da questo punto di vista tutte queste microstorie raccolte tra l’Imperiese e la Carnia, passando per le Valli piemontesi, la Valchiavenna e la Val di Cembra, ci dicono che il ritorno alla montagna non è necessariamente legato alla nostalgia, all’adagio pavesiano del “resta sempre lassù il paese”, ma può essere dettato da motivazioni che attengono alla voglia di mangiare futuro. E qui mi vengono in mente tre esempi, forse meno micro ma altrettanto emblematici, di ritorno alla montagna in cui passato, presente e futuro cercano di combinarsi creativamente. Alludo all’esperienza di un cantastorie, Davide Van de Sfroos, a quella di un noto politologo come Marco Revelli e a quella di uno degli autori di questo testo, padre nobile dei geografi italiani, Giuseppe Dematteis. Cosa tiene assieme un cantautore del lago di Como, all’inizio in odore di leghismo perché cantava lumbard, con il teorico radicale del conflitto tra capitale e lavoro ai bordi del vulcano FIAT, e con il raffinato teorico del milieu socioterritoriale nell’ipermodernità che avanza tra flussi e luoghi? Il ritorno al territorio, l’attenzione al non più e a quelli che non ce la fanno più, al mondo dei vinti, al margine da cui ripartire. Riportando lì, in microprogetti locali, creatività e poetica acquisita nella società dello spettacolo, nell’Università e nell’analisi politica delle classi, e nello studio dei sistemi territoriali. Poteva anche non tornare il Bernasconi Davide a Mezzegra, da cui era partito giovane cantautore in dialetto locale, che qualcuno voleva lingua. Mettendo assieme, come dice lui, il cyber e il folk. Aveva cantato, dando identità a quei paesani raggiunti solo dall’arrancare della corriera, su oltre il lago, vicino al confine ove resisteva l’ultimo mito del contrabbando, come storia di una frontiera oggi diluita nella globalizzazione. Nel transfrontalierato di un proletariato di territorio che si divide nell’economia dei servizi tra Svizzera, il turismo del lago e la città infinita milanese “dove nascono i citofoni e crescono i telefoni”. Poteva continuare ad andare oltre: Sanremo, il Premio Tenco e il Corriere della Sera che aveva allegato al giornale i suoi CD. La società dello spettacolo non presuppone il tornare, ma solo la dittatura del continuare ad andare per galleggiare sull’acqua del successo. Non il tornare all’acqua del lago, con un viaggio dolce da antropologo del territorio, producendo una guida tra “Terra e Acqua” di quindici Comuni, fatta di musica, poesia, tradizione, gastronomia, arte, storia e natura. Forse lui non lo sa ma, con lo stile di Marc Augé etnologo nel metro, ha raccontato paese per paese, microstorie di mestieri, paesaggi, vite di sopravvissuti alla Belle Epoque di grandi alberghi, oggi diventate il lake district di George Clooney, e il meeting globale di Villa d’Este a Cernobbio, per cui noi oggi conosciamo il lago di Como. Con Terra e Acqua, tornando al non più di quelli che stanno dietro le quinte, Davide ha scritto un manuale di turismo lento, di sviluppo locale, di pesca e agricoltura, come va facendo da anni Carlin Petrini nelle Langhe. Certo con la nostalgia di ciò che non è più nel racconto degli anziani, ma con tanta voglia di confrontarsi con il moderno che viene avanti dei giovani, che quando lui mette in scena la guida del territorio facendone uno spettacolo, si sentono protagonisti del cambiamento. Poteva non tornare a Paralup anche Marco Revelli. Figlio di Nuto, il grande scrittore del mondo dei vinti, aveva ben onorato la memoria del padre diventando un intellettuale di riferimento per la sinistra, scavando con i suoi libri nella crisi della politica, sino al suo ultimo “Finale di partito”. Di solito il destino degli intellettuali è, prima o poi, un seggio senatoriale. Non tornare a cercare “il popolo che non c’è più” con la Fondazione Nuto Revelli a Paralup, dove suo padre aveva fatto il partigiano. Tornare a Paralup con i sindaci dei Comuni polvere, della Provincia granda, cercando di rianimare quella montagna da cui si è scesi a valle per andare alla Michelin o alla FIAT, o cercando il capitalismo molecolare nei capannoni del fondovalle. Si cerca di ristrutturare quel borgo abbandonato con manutenzione eco-compatibile, rispettosa del linguaggio dei ruderi dei paesi abbandonanti. Facendoci anche un piccolo rifugio per i tanti che, per fortuna, anche loro con il turismo lento, stanno di nuovo risalendo i sentieri abbandonati dai vinti. E così lui, intellettuale della Torino fordista, si è trovato nelle pastoie burocratiche e legislative di chi vuole aprire una microimpresa come un rifugio con alloggio e cucina in alta montagna. Sarà per questo che anche lui, come me, non è stato impietoso con la protesta dei forconi. Si torna ma non si dimenticano le passioni, infatti ogni anno la fondazione organizza a Cuneo una scuola per la buona politica e un concorso per scrittori migranti, nuovi cittadini che si sperimentano con la nostra lingua. Poteva sentirsi appagato anche il grande accademico Dematteis. Andare in pensione mantenendo un ruolo come professore emerito e dispensare di convegno in convegno il sapere acquisito, o dedicandosi solo alla consulenza ministeriale con Fabrizio Barca sulla coesione territoriale. Ha fondato anni fa un centro studi militante denominato Dislivelli, insieme a giornalisti e ricercatori sul tema del rapporto mai risolto, tra le terre alte, la montagna, e le terre basse della pianura e della città. Interrogandosi con la sperimentazione territoriale, se fosse possibile estendere e aggiungere all’adagio braudeliano città ricca-campagna florida, quello montagna viva e non abbandonata. Partendo, come scrive, dalla constatazione “che la montagna oggi è la più grande riserva di biodiversità e di acqua dolce d’Europa, l’attraversamento obbligato di una grossa parte dei traffici continentali da e verso il Mediterraneo e dall’avere un’economia ed una cultura storicamente basata su potenzialità specifiche dell’ambiente montano”. Quindi, come sostegno da tempo, non è più periferia o margine, ma centro. Anche se vissuta da chi la abita come un’area “triste”. Infatti anche se la geoeconomia ricolloca al centro un territorio, tutto questo non basta se chi lo abita si sente spaesato e vive la modernità che lo attraversa con anomia. È una bella botta di speranza questo testo. Viene descritta una nuova composizione sociale di “montanari per scelta”, che con coscienza di luogo del nuovo spazio di posizione delle terre alte e con cultura del territorio e del fare impresa nella green economy rianimano alpeggi, turismo lento, boschi, agricoltura… I sociologi li definiscono i “ritornanti”, analizzando i numeri dei tanti giovani che tornano all’agricoltura, alla montagna, al territorio. Hanno fatto bene a ritornare sia il cantautore che il politologo che il geografo, sul lago, a Paralup e nelle terre alte, incontrandosi con i tanti che tornano come loro. È un segno di speranza di un possibile non ancora che verrà.
Aldo Bonomi